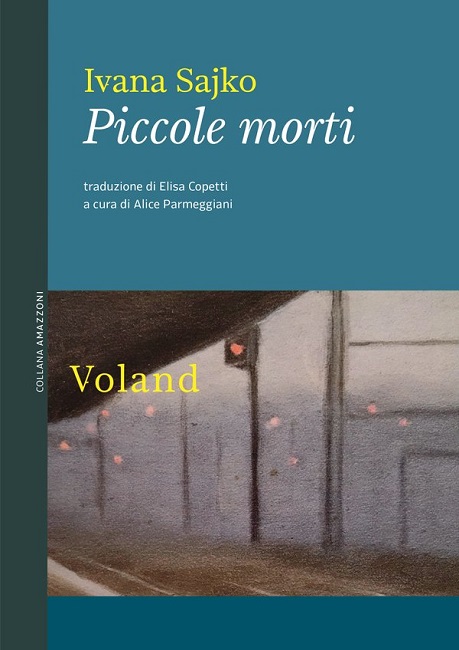Ogni addio, ogni separazione, ogni fallimento è una piccola parte della propria vita che si sgretola in tanti piccoli frammenti, tante piccole morti.
In questo libro, da poco edito da Voland con la traduzione di Elisa Copetti, Ivana Sajko scava nelle miserie e nelle fragilità umane, partendo dal passato tempestato da traumi familiari ed esistenziali del protagonista fino a ricostruire un presente che non è sicuramente il migliore dei mondi possibili. Dove le guerre non sono mai finite, dove i muri sono stati abbattuti ma nessuna “unità” è realmente compiuta, dove inesorabilmente gli uomini sono costretti dalla guerra a scappare dalle proprie case. E da sé stessi.
“Scrivo nell’unico modo che conosco, girando nei meandri di ciò che mi fa più male e per cui non c’è aiuto.”
Cosa troviamo in Piccole morti di Ivana Sajko? Un uomo e il suo viaggio in treno da una piccola località sulla costa meridionale dell’Europa verso Berlino. Un uomo che non sa più viaggiare perché ha dimenticato come ci si abbandona alla vita, alla volontà dei binari, che ha come sua unica ancora la scrittura. Ed è attraverso la scrittura, attraverso il suo taccuino, che si lascia andare a un flusso di coscienza. Un viaggio a ritroso in una storia, la sua, costellata da insuccessi. Un amore finito, l’abbandono della propria città e il fallimento nella sua professione di giornalista e scrittore. Un block-notes su cui fantastica di un viaggio senza ritorno, verso l’illusione di un mondo occidentale che possa regalargli una nuova vita come fu, in parte, per sua madre.
Un vagare, il suo, che nasce dalla fine di una storia d’amore, dove il solo atto di scrivere di questa donna, era un modo per strapparla dalle immagini sfocate della memoria e riportarla indietro alla loro storia, dove il ricordo era lo strumento per riportarla a sé. Poche pagine, Piccole morti, in cui la Sajko riesce a condensare in un intreccio narrativo affascinante e coinvolgente il gioco della vita in tutte le sue declinazioni. L’autrice gioca col tempo e con la prospettiva, avanti e indietro nella storia, affrontando il passato, la perdita e la maledizione dei padri, parla di come la violenza può essere perpetuata attraverso le generazioni, di come si riverbera inevitabilmente sulla vita del protagonista, sulla sua stessa identità.
Attraverso flashback, Ivana Sajko riesce a restituirci eventi del passato determinanti per rivelare momenti chiave del protagonista e capire le battaglie interiori che deve combattere per accettare il fallimento, la volontà autodistruttiva di sprofondare nel gorgo dell’alcol. E ancora, la complessità della elaborazione del lutto, perché ogni perdita, ogni fallimento è una piccola morte, un momento di riflessione intimo e anche universale.
Attraverso appropriate valutazioni, ci descrive uno spaccato dell’attuale situazione europea, un’Europa che è madre senza figli, sulla disumanizzazione dei migranti e sulla violenza subdola della guerra.
“La disuguaglianza nella quale l’Europa sprofonderà indifferente, così come sprofonderà nella sua ipocrisia, nei suoi interessi locali, nella sua cosiddetta democraticità, di cui si serviranno i diversi fascismi in una lotta unitaria contro la ragione, mentre noi finiremo in qualche territorio di confine che funge da zona cuscinetto contro migranti e virus, e dove la miseria di chi si trova già là lavora strategicamente contro la miseria di chi sta arrivando, perché la miseria odia la vista della miseria.”
E allora bisognava andare via, perché tutti se ne erano andati, in silenzio, con discrezione, bisogna capire che “ogni partenza è una piccola morte”. Abbandonare la propria città a cui si era estranei, lasciare lì le proprie miserie, i propri fallimenti e andare alla ricerca di sé stessi, dall’altro capo del binario, in una città dove, da straniero, scevro da ogni vincolo, si spera, riconoscerà qualcosa dell’uomo, dello scrittore che, nascosto in qualche anfratto della sua anima, aspetta solo di vederlo tornare.
“Sentire il mio silenzio come il destino dello straniero che non sapevo narrare, perché la sostanza della sua storia era anche nella sua indicibilità, il mio straniero era muto e invisibile, sebbene lo si potesse vedere ovunque, era uno tra migliaia, uno tra milioni, e proprio la smisuratezza di quei volti di quei corpi di quelle strade di quelle ricerche di quei respingimenti di quelle speranze l’ha reso indescrivibile, e sì, ecco perché dovevo scrivere di lui, sebbene continuassi a non avere altro che il mio silenzio, come lui aveva il suo.”
Emanuela Stella