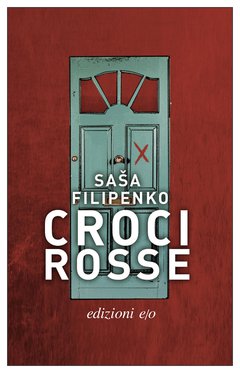Croci rosse è l’ultimo romanzo di Saša Filipenko uscito per i tipi di edizioni E/O. Tra le sue pagine scorgiamo la contraddittoria Bielorussia di oggi passando per le memorie taciute dell’era sovietica.
Perché vivevo? Vivevo perché stavo ancora aspettando.
Cosa significano queste croci rosse sui portoni? Saša si è appena trasferito a Minsk, il suo appartamento è vuoto, come la sua esistenza. Entrambi sono in attesa di un nuovo inizio. Ma quelle croci rosse sui portoni, sul suo portone, lo infastidiscono. Lo inquietano. È un’invadenza da parte del mondo esterno. Deve assolutamente eliminarla.
Saša è “un uomo-baratro con sopra un ponte sospeso”, non ha intenzione di superare l’infelicità, di buttarsi per arrivare dall’altra parte. Eppure deve farlo e il nuovo appartamento di Minsk, nel quale andrà a vivere con la figlioletta di tre mesi, è il primo passo per costruire un futuro al proprio dolore. Quelle croci rosse sono un’intrusione inaspettata, lo costringono a fermarsi, ad accantonare la risalita.
Le croci le metto per ritrovare la via di casa. Certo, fra poco scorderò cosa significano…
Tat’jana Alekseevna entra nella sua vita, nella sua nuova vita, con queste parole. La donna, una novantenne con l’Alzheimer galoppante, spinge con le spalle al muro il ragazzo costringendolo a fare i conti con la Storia. In una Bielorussia d’inizio millennio, intrisa di retaggi di regime, i due vicini di casa compiono un viaggio a ritroso; insieme scoprono quanto sia fatuo il concetto di libertà e quanto invece gravi la paura sulle scelte di ciascuno e sulle relative conseguenze.
Nei racconti di Tat’jana sfilano i volti a cui non ha potuto dire addio, s’intrecciano le colpe di chi si è macchiato del loro dolore. Nelle sue parole si accavallano i rimpianti, le attese e il desiderio di proseguire per non di menticare, per difendere delle croci che un nuovo e ipocrita oblio vuole asfaltare, mettendone a tacere il ricordo.
Parlano, Saša e Tat’jana, con riluttanza lui, con cieca fiducia lei. Si frugano con gli occhi e con le parole in cerca di speranza: la speranza di poter ricominciare e quella di poter dire addio. Si salvano a vicenda davanti a una tazza di tè in una città che non appartiene a nessuno dei due.
La narrazione è impetuosa come un fiume, puntuale e ricca di dettagli. L’urgenza di Tat’jana di affidare la sua storia a qualcuno che la possa serbare è palpabile. Date, città e documenti ufficiali arricchiscono un racconto pulito, lucido e avvincente. La donna non ha inibizioni nel mettere a nudo la propria vicenda, anzi ha fretta di farlo perché la sua memoria ha il timer già impostato. A far da contraltare ai suoi racconti v’è il viaggio di Saša nel proprio passato. Questo ha un incedere più intimo. È un sussurro delicato che parla di amore e dolore, di bellezza e tristezza. La corsa di Tat’jana è invece contro il tempo: l’anziana non deve metabolizzare la sofferenza, l’ha già vissuta fino in fondo. Il suo compito ora è quello di consegnare le sue croci rosse a chi saprà piantarle ben salde nel terreno e deve farlo prima che scompaiano per sempre.
Tat’jana trascorse la propria giovinezza in giro per l’Europa, ciò dopo la laurea le garantì un posto come traduttrice della corrispondenza diplomatica al Commissariato del popolo agli Esteri. Tra il ’35 e il ’37 si sposò, mise al mondo la sua bambina e vide sparire nel nulla il suo migliore amico insieme a molti altri volti conosciuti. Erano iniziate la grandi purghe staliniane, tutti erano dei potenziali traditori. La paura serpeggiava, nessuno era immune al sospetto.
Lì per lì avevano pensato che a salvarla fosse stato il suo nuovo cognome, Pavkova. Erano convinti che prendessero solo i non-russi: polacchi, tedeschi, ebrei. Ma presto quella teoria crollò. Dall’interno 29 portarono via Maša Gavrina, russissima, e dal 31 l’altrettanto russo Pëtr Andreevič Chrisanov. Nazionalità e professione persero ogni valore. Perché a non ripresentarsi a lavoro erano autisti e radattori, diplomatici e galoppini.
Tat’jana non intende trattenere i ricordi. Quando nel ’41 il marito partì per la guerra, la sua esistenza si fece più dura. Lavorava senza sosta, ogni giorno arrivavano dispacci della Croce rossa con gli elenchi dei prigionieri. Per l’URSS i soldati caduti in mano al nemico divenivano traditori, così anche le loro mogli e i loro figli. Tat’jana temeva di trovarvi il nome del marito. Temeva per lui. Per sé. Per la loro bambina. Quando ciò accadde, tutto assunse una differente prospettiva. Anche la paura cambiò sapore.
Si sentiva come il condannato a morte che attende nell’ultima cella, ma che non viene mai giustiziato. La pistola era già contro la tempia, la canna fredda le sfiorava la pelle, ma il boia non premeva il grilletto. Un giorno, due, venti. Di lì a qualche mese era talmente sfinita che pensò di consegnarsi lei stessa.
La storia della donna si alterna a quella di Saša. Alle sue croci. Si tratta di una narrazione più pacata, ma altrettanto urgente. I ricordi recenti del ragazzo ricuciono l’intero racconto. Saša ben comprende che nessuna croce merita l’oblio. Neanche la sua. La memoria ha il dovere di curare le ferite inferte dalla paura.
Leggi anche la recensione de Il dolce domani di Banana Yoshimoto
Saša Filipenko ha ricostruito la Storia donando al lettore un’inevitabile fusione tra realtà e letteratura. In un contesto storico e sociale intriso di un negazionismo che tende a fare terra bruciata, lo scrittore ha ricostruito l’avventura esistenziale di Tat’jana a partire da documenti autentici. Con una penna diretta e semplice, Filipenko ha consegnato a noi tutti un'”autobiografia della paura” nella quale si mescolano timori, colpe e attese in un crescendo emotivo.
Ho chiesto se potevo piantare una croce; mi hanno detto di no: le croci non erano autorizzate. E chissenefrega, pensai. […] Torno ogni anno a controllare che ci sia ancora. C’è. Sottile, ma alta quanto me. Semplice, ma fiera. Esattamente come la volevo.