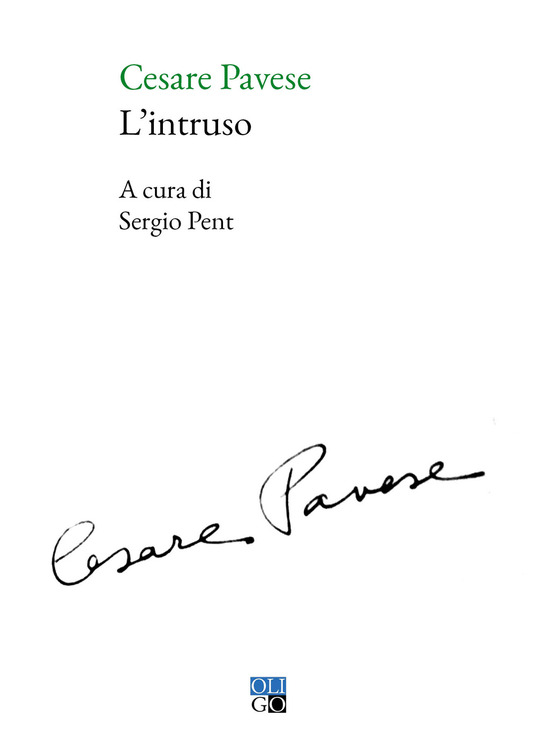Chi può essere definito intruso in una data fase storica?
Per rispondere a questa domanda ci è certamente utile analizzare il periodo in questione. È il 1937, in Italia il regime fascista gode ancora di enorme consenso, forte della “trionfale” vittoria nella guerra d’Etiopia e la susseguente nascita dell’Impero. Il “genio latino indomito”, così come Gabriele d’Annunzio appellò Benito Mussolini, è sempre più duce di una Penisola stregata dalla sua verve, un Paese che cinge come una maliarda dea pagana, in ambiguo bilico tra promessa e illusione. Ma quell’anno, per il fascismo, è anche l’inizio della fine: Mussolini è ormai succube di quell’Adolf Hitler che fino a pochi anni prima vedeva come una scimmia ammaestrata, un ridicolo esaltato da non prendere sul serio, e che ora reputa, invece, un grande uomo e un genio della politica, da seguire fedelmente per mettere le mani, assieme, sull’Europa e sul mondo. Il duce si reca nella Germania del Führer che lo catechizza sulle prossime azioni da compiere: l’allievo ha superato il maestro, il pupo è diventato puparo. Arriva l’alleanza, si dà il via all’introduzione in Italia delle leggi razziali, viene stipulato il famigerato Patto d’Acciaio, il disastro della Seconda guerra mondiale è ormai prossimo.
Ora, tratteggiato il contesto, è facile rispondere alla domanda iniziale. Nel 1937 un intruso è semplicemente un uomo non allineato al nuovo ordine fascista, protesto fatalmente a compiacere il gran capo tedesco. O semplicemente un uomo che non sa scegliere, che vacilla, che comincia a porsi domande. E questo per il regime vale già come essere dall’altra parte, un nemico.
Dal confino politico alle prime pubblicazioni
Quest’uomo irresoluto è Cesare Pavese, ritornato da un anno da Brancaleone, paesino dell’estrema costa ionica calabrese in cui è stato confinato dall’agosto 1935 al marzo 1936. È un Pavese che ha ricevuto la delusione amorosa battistrada delle tante che indirizzeranno la sua esistenza – segnatamente, quella che gli ha inflitto la militante antifascista Tina Pizzardo, causa, tra l’altro, della sua condanna al confino – e che ha da poco dato alle stampe la sua prima silloge dal titolo Lavorare stanca. Quello del 1937 è, inoltre, un Pavese che cerca di sbarcare il lunario con qualche traduzione dall’inglese – ricordiamo che è lo scrittore e poeta di Santo Stefano Belbo a portare in Italia le opere di Herman Melville, John Dos Passos e John Steinbeck – e con qualche supplenza. Frattanto, inizia a scrivere anche in prosa, componendo bozzetti per futuri romanzi e racconti come L’intruso, ripubblicato oggi da Oligo Editore nella collana Daimon.
L’intruso è un breve racconto di Cesare Pavese scritto sì nel ’37, ma pubblicato soltanto nell’ottobre del 1950, due mesi dopo il suicidio dello scrittore langhetto tra le mura dell’Albergo Roma di Torino, sulle pagine della rivista “Rinascita”, diretta da Palmiro Togliatti, segretario generale del Partito comunista italiano e deputato della Repubblica.
I temi de L’intruso di Cesare Pavese
Nel racconto si assiste al dialogo tra due uomini in carcere, uno giovane e uno di mezza età. Il ragazzo, tratteggiato sul profilo dello Stefano del romanzo autobiografico Il carcere, è inquieto: legge, saetta per lo spazio angusto in cui è costretto, tenta di capire come gestire il tempo vuoto della prigione, preso dall’“affanno del domani”; l’anziano, invece, è schivo e disincantato e non tollera la frenesia del compagno di cella, sostenendo che in “carcere non si deve far niente, e lasciar che il tempo passi”, ché un uomo come si deve è bastevole a se stesso, non necessita d’altro e può benissimo fare a meno della gente.
Due filosofie differenti che finiranno per cozzare in un piccolo lavoro in cui si riscontrano già alcuni dei temi più cari a Pavese: il selvaggio, la solitudine, la passione, la melanconia, le angosce, il male di vivere.
In conclusione, qualcuno potrebbe storcere il naso per il prezzo di copertina di dodici euro, sproporzionato, all’apparenza, per un librino di trentasei pagine. E invece no, perché, se oggigiorno siamo abituati a spendere diciotto o venti euro per leggere le trecento e più pagine “scritte” dall’esagitato capo di partito o dal rapper più à la page del mese, dodici euro per scoprire una nuova trentina di pagine del caro e vecchio Cesare Pavese, se ci pensiamo, non sono affatto assai.
Leggi anche Cesare Pavese e la scoperta della sua America in un nuovo libro
D’altronde, come sostiene il critico letterario Sergio Pent nella bella introduzione del volume, “Pavese non è invecchiato, non è dimenticato, non ha perso lo smalto […] Pavese è ancora oggi uno scrittore in divenire”.
Antonio Pagliuso